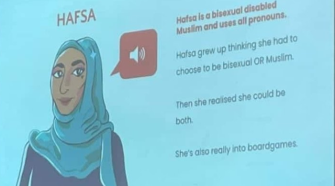Mentre il ddl Zan approda (e si blocca) tra le polemiche in Commissione Giustizia al Senato, compaiono le prime crepe nell’ampio schieramento dei sostenitori, insieme a qualche piccola defezione in quello degli oppositori. A dimostrazione che si tratta di un testo di legge “divisivo” come è stato detto da più parti.
Che esso rappresenti una minaccia alla libertà di espressione, nonché al “pluralismo delle idee” e alla “libertà delle scelte” è già stato argomentato su questo giornale, in compagnia di (pochi) altri. Che rappresenti una minaccia alle conquiste delle donne è qualcosa invece di cui le donne hanno incominciato ad accorgersi solo recentemente. Eppure esso costruisce un modello di società diametralmente opposto a quella basata sulla parità dei sessi, creando un immaginario idealtipo di maschio etero (e sano) che non esiste nella realtà ma che viene eretto a norma mentre tutto il resto rappresenta “l’altro”.
Un festoso treno nel quale alle donne è stato astutamente assegnato il ruolo di locomotiva al traino di una serie di vagoncini di minoranze “sessuali” e i disabili sono stati cinicamente agganciati come ultimo vagone per rendere il convoglio più vendibile. Cosa ne pensino i disabili non lo sappiamo. Io personalmente – che con la disabilità ho un rapporto molto stretto – non apprezzo affatto: non mi entusiasma la possibilità di fare causa all’idiota che si permettesse di insultare chi mi è caro, e al posto di una legge a costo zero (“senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”) preferirei qualche soldo in più da investire per esempio in insegnanti di sostegno, ausili tecnologici o eliminazione di barriere architettoniche.
Il pensiero delle donne in materia, invece, si è complicato da quando alcuni settori di sinistra della società civile, in larga parte associazioni del femminismo storico di matrice comunista (Udi, Arci) o del femminismo di ultima generazione (Se Non Ora Quando) tra cui spicca anche una nota associazione di lesbiche (Arcilesbica) si sono improvvisamente svegliati accorgendosi che il ddl riduce le donne ad una “sfumatura dell’arcobaleno Lgbt”. Eppure è un processo che va avanti da decenni e viene da chiedersi dove erano le femministe quando hanno incominciato ad apparire nelle manifestazioni, almeno vent’anni fa, i primi striscioni inneggianti a “Donne e lesbiche” che suscitavano le perplessità di mia figlia (“Mamma, ma le lesbiche non sono donne anche loro?”).
Dove erano le femministe quando l’acronimo Lgbt – che va ogni giorno allungandosi di nuove iniziali e si è trasformato in un catalogo di pratiche sessuali – veniva agganciato alla parola “donne”, senza mai venir messo in discussione, ogniqualvolta si parlava di “diritti”? Purtroppo lo sappiamo: hanno accolto con ingenuo entusiasmo una operazione culturale che andava contro le donne e le loro conquiste. Un operazione culturale – come mai non se ne sono accorte? – promossa in primis dagli uomini, tant’è che coloro che hanno incominciato allora a chiamarsi gay hanno promosso la propria cultura e le proprie rivendicazioni quando ancora le donne non si ponevano il problema dell’omosessualità femminile, socialmente molto più accettata per motivi di cui non possiamo occuparci qui. E non c’è chi abbia una qualche dimestichezza con il mondo dell’omosessualità maschile che non sappia che esso si divide abbastanza equamente tra una componente sinceramente woman-friendly e una componente ferocemente misogina.
Così le donne hanno finito per lasciarsi intrappolare nella furia del dibattito ideologico cui oggi assistiamo, creato e trainato dalla politica dei partiti (in mano agli uomini) la cui esclusiva premura è stata quella di posizionarsi secondo i vieti schemi destra-sinistra, con un occhio al loro elettorato di riferimento ed un altro a quello potenziale. Solo così è potuto passare alla Camera ed approdare al Senato, senza che né l’accademia né gli ordini professionali alzassero un sopracciglio, un disegno di legge che nel suo primo articolo ci scodella una serie di definizioni da manuale di sociologia o psicologia. Salvo che queste, essendo legge, non sono, come la scienza richiede, né discutibili né falsificabili.
A cominciare da quella di “genere”, definito “manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso”. Cioè praticamente qualsiasi comportamento. Come mangiamo, come ci vestiamo, come facciamo l’amore, come viviamo in famiglia, come studiamo e come lavoriamo, come votiamo e come preghiamo, come pensiamo e come scriviamo … sfido a trovare un solo comportamento che non sia conforme o contrastante con le “aspettative sociali connesse al sesso”. E quindi passibile di rientrare nella fattispecie della legge. Mentre il contenuto effettivo delle aspettative sociali, la loro analisi critica, le modalità con cui vengono costruite, la loro evoluzione o trasformazione diventano questioni irrilevanti. Esonerando così tutti quanti, ma in primis quanti detengono quote di potere politico o normativo, da un paziente lavoro di analisi e costruzione delle politiche pubbliche, dei processi educativi, delle pratiche mediatiche, volti a conseguire obiettivi che vadano al di là della “prevenzione e contrasto”, fornendo strumenti di monitoraggio e facendo obbligo di un qualche periodico resoconto del loro raggiungimento.
Si fa così piazza pulita del concetto di genere fatto proprio dal femminismo della differenza (quello che ha seguito il femminismo emancipazionista del diritto di voto e quello welfarista delle pari opportunità). Un concetto che in Italia si è fatto strada essenzialmente grazie all’unificazione europea e che per “genere” intende semplicemente la costruzione sociale dei ruoli sessuali. Significa, in parole povere, che se la differenza sessuale ha radici biologiche a queste ogni società ci aggiunge del suo, producendo una varietà infinita di ciò che è considerato di volta, a seconda delle epoche e delle latitudini, appropriato per i maschi e appropriato per le femmine. Differenziare il sesso dal genere, in questi termini, è stata una conquista importantissima per le donne: laddove le società patriarcali per secoli sono andate nella direzione di attribuire alla natura una serie di presunte “inclinazioni” della donna (per esempio la cura della casa) e di presunte “incapacità” della donna (per esempio fare politica o esercitare la magistratura) nonché una serie di presunte “attitudini” esclusivamente maschili (il comando, la guerra, il rapporto con il sacro), la distinzione tra sesso e genere ha permesso di rimuovere una serie di limiti che riguardavano specialmente le donne, aprendo loro la strada ad una più ampia realizzazione di sé. Ne hanno peraltro beneficiato anche gli uomini ai quali sono stati aperti, per esempio, spazi fino ad allora tabù per i padri, dalla stanza del parto alla nursery: alcuni hanno molto gradito.
Dal concetto di genere è derivato uno dei più importanti strumenti a favore delle donne in materia di politica pubblica: il cosiddetto gender mainstreaming (letteralmente “inserimento del genere nella corrente dominante”). Con questa espressione si intende la valutazione comparata dell’impatto di ogni legge o politica pubblica, in tutti i settori e a tutti i livelli, rispettivamente sugli uomini e sulle donne. Per esempio, applicando questo concetto, una serie di amministrazioni locali hanno smesso di darsi per obiettivo dei generici “impianti sportivi per i giovani” e si sono chieste concretamente quale impatto questi impianti avrebbero avuto rispettivamente su giovani ragazzi e giovani ragazze. Per giungere alla conclusione che se si limitavano a fare il solito campo di calcio che avevano in mente la cosa avrebbe promosso assai di più la pratica sportiva dei maschi che non quella delle femmine. Del pari, l’obbligo di includere nei progetti di ricerca accademici gli indicatori di impatto di genere, pena l’esclusione dai finanziamenti europei, ha improvvisamente sdoganato nelle università i gender studies, cioè tutta la ricerca sociale sulle relazioni tra i sessi, fino ad allora appannaggio quasi esclusivo delle ricercatrici e considerata materia marginale.
Successivamente, a questo concetto analitico di “genere” si è sovrapposto il concetto ideologico di “genere”. Questo col tempo ha finito per sostituire, puramente e semplicemente, il termine “sesso”, spesso in omaggio ad una malintesa correttezza politica che ha finito per rendere tabù ogni riferimento al sesso (come ai tempi di mia nonna). Lo possiamo vedere oggi nel linguaggio mediatico, nel linguaggio burocratico, e nel linguaggio della strada pappagallescamente a rimorchio degli altri due. Con effetti talvolta comici come quando si parla di spazio, lavoro, attività o quant’altro aperto “ad ambedue i generi”, come se fosse vergognoso dire “ad ambo i sessi”. Il passo poi è stato breve a suggerire che, una volta sostituito completamente il “genere” come costruzione sociale al sesso come dato biologico, non stava scritto da nessuna parte che i generi dovessero essere due: potevano essere tre, quattro, e via dicendo, a seconda del numero potenzialmente illimitato di “manifestazioni esteriori” conformi o contrastanti con le rappresentazioni sociali di uno dei due sessi ma anche di tutte e due o anche di nessuno dei due.
In questa sostituzione linguistica niente affatto innocente chi ci ha perso sono state le donne. Erano appena riuscite ad imporre l’abitudine di pensare la società come fatta di uomini e donne, anziché di soli uomini (come da plurale maschile assunto a universale), erano riuscite ad istillare i germi di questo approccio non solo nelle politiche di welfare ma anche nelle politiche urbanistiche e nella pianificazione economica – cioè in settori di pertinenza tradizionalmente maschile, che producevano un mondo visto con occhi di maschi – ed eccole ridotte al grado zero delle variegate identità di genere. Erano riuscite ad imporre la doppia declinazione al maschile e al femminile di titoli, professioni nonché di aggettivi e sostantivi usati al maschile per ogni aggregato plurale in cui fosse presente anche un solo maschio, ed ecco che questo riconoscimento della “doppia sovranità” viene sostituito da asterischi e altri simboli che neutralizzano la differenza sessuale.
Questa operazione, culturale innanzitutto, ripropone l’Uomo nel senso di maschio quale referente per default dell’umanità intera che però non trova più di fronte a sé, a resistergli, quella irriducibile alterità femminile che tanto lo spaventa. All’alterità femminile vengono ora agganciate alterità basate sull’orientamento sessuale che la legge definisce “attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi”. Cioè praticamente su ogni pulsione o sentimento positivo provato da chiunque nei confronti di chiunque. La differenza ontologica tra i sessi viene così ridotta sul versante femminile a una delle tante forme di alterità minoritaria che questa legge paradossalmente viene a configurare come deviazioni (determinate da un quantum variabile di biologia, un quantum variabile di cultura e una parte preponderante di soggettività inconoscibile e insindacabile) dal gold standard della sessualità umana incarnato dal maschio “abile”.
Quest’ultimo vede anzi ampliato il suo campo normativo e può ora fantasticare di una società di soli uomini, in cui le donne sono ridotte a mero ricettacolo del suo seme, così come le rappresenta il dio Apollo nelle Eumenidi di Eschilo quando afferma: “Quello che si dice figlio, a concepirlo/non è una madre, lei è solo nutrice di un seme/lo concepisce il maschio e lei, indifferente/ne custodisce il germe …”. Per chi non lo sapesse sono parole che il dio pronuncia in difesa di un matricida.
Come mai le donne ci sono cascate? Come hanno potuto confondere parità con dedifferenziazione sessuale? Forse per la cattiva coscienza di origine marxiana, quella che alle femministe sussurrava che non è la stessa cosa essere una donna ricca o povera, bianca o nera, sfidando così l’assunto di base del femminismo secondo cui è “dato di fatto dimostrato dall’analisi della realtà che esistono disuguaglianze sistematiche tra uomini e donne che sono trasversali a tutte le altre disuguaglianze (di età, orientamento sessuale, etnia, religione, ecc.)” ? Forse perché, incapaci di reggere il peso delle aporie generate da questi assunti che la loro soggettività percepisce come veri ambedue, le donne hanno pensato di poterle superare facendosi carico di tutte le “diversità” che di volta in volta si affacciano sulla scena sociale e politica?
Certamente in questo senso è andata la diffusione del concetto di “intersezionalità”, al quale hanno fatto ampio ricorso i movimenti di gay e lesbiche per agganciarsi a quello delle donne. “Intersezionalità” – che designa l’intersecazione, in singoli individui e gruppi sociali, tra molteplici fattori di discriminazione – è un concetto introdotto, alla fine degli anni Ottanta, dalle femministe afroamericane per criticare il femminismo “bianco”, accusato di cecità nei confronti del fattore razziale e del suo “intersecarsi” con il genere (inteso ancora come insieme di ruoli sociali legati al sesso). E’significativo che esso sia stato formulato da una giurista, Kimberlè Crenshaw, interessata a questioni molto concrete quali l’applicazione del Titolo VII del Civil Rights Act del 1964 (la sezione della legge federale antisegregazionista che si occupa di discriminazioni nei rapporti di lavoro basate su razza, colore, religione, sesso o origine nazionale) e l’implementazione delle politiche femministe negli Usa.
Il concetto ha riscosso un grande successo, allontanandosi parecchio dal pensiero e dalle preoccupazioni – così attuali tuttora negli Usa – di chi lo ha formulato originariamente. Se da un lato è stato utilizzato dai sociologi per analizzare come in ogni società vengono costruiti gli standard di normalità e desiderabilità in contrapposizione a ciò che viene considerato “altro” o “deviante”, dall’altro è stato utilizzato da gruppi e attivisti della società civile per reclamare lo status di “discriminati” ai portatori di un numero crescente di caratteristiche fisiche, psicologiche, culturali, attitudinali. Con la fondamentale differenza che mentre per i sociologi della scuola costruttivista qualunque di queste caratteristiche può determinare un privilegio positivo o negativo a seconda del contesto storico e sociale, per gli attivisti intersezionalisti ognuna di esse tende ad assurgere a status ontologico e componente ascrittiva di quella cosa che chiamiamo identità. Dando così origine al proliferare di sottogruppi identitari che finiscono inevitabilmente per entrare in conflitto tra di loro, nella misura in cui i loro componenti diventano simultaneamente oppressi e oppressori.
E’ esattamente quello che sta succedendo oggi in Italia dove i primi conflitti legati alle appartenenze multiple sono emersi con lo schierarsi di associazioni di lesbiche nel campo più ampio dei movimenti delle donne (e i feroci attacchi venuti dal campo gay). Se la legge passa potrà in futuro dare molto lavoro agli avvocati proprio come succede negli Usa. Al contempo inasprirà la competizione, endemica nella società civile, tra gruppi e associazioni che vogliono assicurarsi una quota delle risorse materiali (budget) e immateriali (visibilità e riconoscimenti) messe a loro disposizione dai pubblici poteri. Dell’importanza di queste risorse è spia la lunghezza degli articoli 7 e 8 del ddl Zan, comparata alla brevità di quelli che definiscono l’identità sessuale o introducono clausole di salvaguardia della libertà di espressione.
L’articolo 7 è dedicato all’Istituzione della “Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia” in occasione della quale andranno organizzate “cerimonie e incontri” nelle scuole e nelle amministrazioni pubbliche. A parte il fatto che queste formulazioni fanno venire in mente irresistibilmente i rituali dei Balilla e delle Piccole Italiane c’è da chiedersi come mai accanto all’omofobia sia stata introdotta la lesbofobia: forse che il termine, che ha in comune con quello di omosessualità la radice greca homos cioè “lo stesso”, non designa l’avversione all’omosessualità sia essa praticata da uomini e donne? O forse questa aggiunta è un piccolo lapsus che rivela quanto questa legge sia fatta sostanzialmente per i maschi i quali, ben sapendolo, sentono il bisogno di aggiungere qua e là le donne, le lesbiche e la misoginia per smentirlo? E non saranno soprattutto gli uomini, invidiosi delle azioni positive destinate alle donne e degli spazi che sono venute conquistandosi, a non vedere l’ora di partecipare, con le loro “associazioni impegnate nel contrasto delle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere” alla istituenda “consulta permanente delle amministrazioni locali e delle associazioni di categoria” per l’elaborazione della “strategia nazionale triennale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere” come da articolo 8 (in questo caso il linguaggio ricorda quello di sovietica memoria o quello della Cina contemporanea)? In ogni caso, poiché tutto andrà fatto senza un soldo in più e poiché il ddl ha generosamente inserito anche le donne è prevedibile che le risorse per tutto questo andranno attinte a quelle fino adesso a loro destinate esclusivamente.
Si tratta forse di piccole cose ma da queste bisogna partire per rispondere all’accattivante slogan secondo il quale la legge “dà più diritti a chi non ne ha” (e quindi che problema c’è?). Perché questa, come ben sanno i politici e come argomentano giuristi e sociologi, si configura come una partita a somma zero nella quale quanto viene riconosciuto agli uni viene sottratto ad altri. Sta già succedendo (il diritto ad essere nominato come padre o madre, per esempio, sui documenti dei figli minori, è sacrificato ai diritti di coloro che padri o madri non possono essere; il diritto dei figli di conoscere i propri genitori biologici è sacrificato a quelli di coloro che “li hanno voluti” – ma dovremmo dire “comprati”).
Ed è anche fuorviante attirare l’attenzione esclusivamente sugli aspetti penali della legge. Essa infatti pone le basi, in quei lunghi e burocratici articoli 7 e 8, per un processo educativo e culturale di cancellazione del dualismo maschile-femminile che per la filosofa Hannah Arendt – la quale cita la Genesi: “Maschio e femmina Dio li creò” – è fondamento originario dell’ontologica ed esclusiva pluralità umana. Da valore questo dualismo diventa così un disvalore, in nome della “cultura del rispetto e dell’inclusione”. E contestare l’asimmetria di potere e privilegi tra uomini e donne, che non è affatto superata, diventerà più difficile.